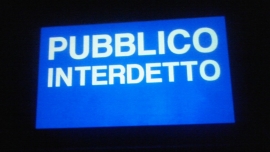"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)
Cavalo Dinheiro (Pedro Costa)
Wednesday, 15 April 2015 15:20Il cuore messo a nudo e la mente che cancella
Naked
Due spettri continuano ad aggirarsi per l’Europa, quelli di Ventura e Pedro Costa, un sottoproletario e un artista. Già questo basterebbe a farci sussultare, ma c’è di più. Pedro è un sincero intellettuale che ama il prossimo suo e conosce Baudelaire, non si avventa sugli sfruttati coi metodi sgarroni italiani né propina quelle camurrìe cattocolonialiste da “documentaristi europei”; piuttosto abbraccia Ventura come Nietzsche il cavallo a Torino. Mette il suo cuore a nudo, cosciente che per essere sublime senza interruzione deve vivere e dormire davanti a uno specchio, lo trova in Ventura. Entrambi non trovano posto sulla terra, la Civiltà della guerra e delle macchine ha sostituito queste agli uomini e alle bestie, e come non ha più bisogno dei cavalli e dei fanti ne ha ancor meno dei “cantori”. Ce le suonano e se le cantano da soli e il sottoproletariato e gli artisti sono gli strati che più ingrossano le fila nei tessuti marci dell’uomo d’inizio millennio.
Ventura che attraversa bui tunnel sotterranei, scosso dal Parkinson e frantumato dalla fatica, ricorda molto più Eusébio da vecchio che Ethan in The Searchers. Anche Pedro, che non possiede il piacere di De Oliveira, che non prova la voluttà di Monteiro, somiglia molto più a CR7 e Mou, ossessionati dalla perfezione e divorati dall’ansia di prestazione. D’altronde il cinema (inteso come accumulo dello spettacolo) e lo sport sono le due vie offerte ai dannati della terra e della storia dopo che la Civiltà dalle radici giudaico-cristiane ha ottenuto il trionfo in tutti i campi, soprattutto quelli di concentramento. Ventura e Eusébio hanno una storia in comune ma un fato opposto. Pedro Costa e Ventura hanno una storia opposta ma un fato comune e come in una fiaba di Sergio Citti partono, questa volta per le cornici del Purgatorio. Non sono sicuri che in vetta si trovi ancora il Paradiso Terrestre, affrontano questa odissea senza Itaca e senza Nostos ma piena di Saudade (qui come nostalgia del futuro), sperando di incontrare Euridice e farla sparire come l’inconsolabile Orfeo di Pavese/Straub.
Non è dato sapere come va a finire, Pedro rimane dietro una finestra come Irene nel finale di Europa ‘51 mentre Ventura un po’ più avanti si riflette sulla vetrina di una coltelleria.
Pare che il primo bisbigli: “Io cercavo, piangendo, non più lei ma me stesso. Un destino, se vuoi. Mi ascoltavo.”, mentre l’altro urla: “La stagione che avevo cercato era là in quel barlume. Non m’importò nulla di lei che mi seguiva. Il mio passato fu il chiarore, fu il canto e il mattino. E mi voltai”.
O Velho do Restelo (Manoel de Oliveira)
Thursday, 16 April 2015 23:09Dislimiti e metamorfosi cosmiche
Roberto Turigliatto
“Che vittorie, che vittorie?”
Le acque dell’Oceano di Amor de Perdição, da cui riaffiorano le lettere di Simão dopo il tonfo dei due corpi negli abissi, sono le stesse da cui in O Velho do Restelo, “nascono” Le Lusiadi, emergendo a loro volta tra le onde? Tra i meandri di questi 18 minuti di strati sovrapposti, di doppi fondi e di fili solo apparentemente disvaganti, Oliveira orchestra un giocoso e potente “montaggio delle attrazioni” in cui si alternano in scena (o nello studiolo della sua mente come specchio magico) Don Chisciotte e Camões, Teixeira de Pascoais e Camilo Castelo Branco, citazioni da Doré e Kosintzev, oltre che dai propri stessi film. O Velho do Restelo riunisce Spagna e Portogallo come unica, strana penisola tra oceano e deserto, tra Atlantico e Sahara, in cui si giuntano e si dissolvono in cifrato destino di disfatta e di perdizione i fantasmi di Don Sebastião e di Don Chisciotte, di Camilo il Penitente e del vegliardo sentenzioso del V Canto delle Lusiadi.
Ormai i film bellissimi (tra i più belli degli ultimi due o tre anni) frutto del lavoro di ripensamento e di riscrittura operato da diversi autori con frammenti dei loro film precedenti (o anche con film interi), sono tanti, uno diverso dall’altro, e solo apparentemente “testamentali”, anzi animati da un’energia che saltella e danza agilmente ora giocosa ora disperata sui dislimiti di metamorfosi cosmiche: Paulo Rocha (Se eu fosse ladrão…roubava), Bressane (Rua Aperana e O Batuque dos Astros), Cardoso (Bacanal do Diabo), Tonacci (Já visto, jamais visto), Straub (Kommunisten). Un movimento che era stato preannunciato fin dal 1988 da Pollet nel misconosciuto Contretemps, il cui titolo polisenso (musicale ma non solo) può forse riunirli tutti. La sublime e inattuale pratica del ripensare e del riscrivere, infinita e rischiosa, era già di Cervantes quando a dieci anni di distanza dalla prima intraprese la seconda parte del Don Chisciotte (dopo l’apparizione della prosecuzione apocrifa), un libro a sua volta intessuto nella pura costruzione metaletteraria, nell’autocitazione e nel montaggio. Oliveira non ha potuto realizzare il suo Don Chisciotte, ma O Velho do Restelo rappresenta (attraverso il vortice intertestuale con Camões, con Camilo, con Pascoais e con… Oliveira stesso!) la più sorprendente rilettura di questo romanzo dall’ “ironia ineguagliabile” e suo tramite di tutta l’opera sempre più labirintica ed enigmatica del suo lettore ultracentenario, sulla cui ironia possiamo a nostra volta sicuramente scommettere.
Dumb and Dumber To (Bobby Farrelly e Peter Farrelly)
Thursday, 16 April 2015 23:03Qualcosa è cambiato
Daniela Turco
Jim Carrey, alcuni mesi fa, in occasione dell’uscita del sequel, vent’anni dopo Dumb and Dumber, a una domanda sui suoi progetti futuri rispondeva: “Distruggere Hollywood”, aggiungendo che, molto probabilmente, aveva già iniziato a farlo. Dumb and Dumber To corrisponde istintivamente a questo desiderio e lo mette in atto, con lo stoccaggio massiccio di elementi solitamente intrattabili, in quanto radicalmente inappropriati, se non apertamente banditi dalla forma-commedia, fatta eccezione per le leggendarie sperimentazioni, macabre e sublimi, di Wilder e Edwards - via Stroheim - condotte dentro e contro Hollywood, che trovano qui una sorprendente continuità.
Malattia, handicap, demenza, vecchiaia, cateteri, ospizi, agenzie funebri, disfacimento, scorie e liquami organici di ogni tipo, morte: a squadernarsi c’è un intero catalogo, indigeribile e sovversivo, che riconfigura quei materiali che hanno sempre strutturato il naturalismo, in cui Dumb and Dumber To si potrebbe iscrivere come reperto regressivo, destinato all’autodistruzione, nel micidiale intreccio che lo muove tra esplorazione pulsionale, spostamento e ripetizione.
Harry e Lloyd sono ancora una volta insieme, anche come materializzazione del doppio e autoironico rispecchiamento degli stessi fratelli Farrelly, che li immergono senza scampo in un on the road sgangherato che, ricalcando la serialità infinita di occasioni mancate del primo, non smette di sfuggire, e qui sta la sua grande singolarità, a ogni reale confronto. Niente qui, infatti, sembra più funzionare, dai tempi comici delle gag, disinnescati o largamente sabotati, alla stessa scorrettezza, drasticamente impoverita, dei contenuti. Alla fine, nella coazione a ripetere, qualcosa è davvero cambiato; non si sorride più dell’innocente malizia dei pupazzi di neve con la carota piantata nel posto sbagliato, o di certe pedicure surreali, eseguite a colpi di sega elettrica. Cosa rimane, allora? I resti, l’insopprimibile vitalità negativa delle pulsioni, il defilè degli oggetti “piccolo a”, il poster polveroso di Bo Dereck in Ten, le gabbie per uccellini, ovvero la prigione ossessiva dei tic di linguaggio, il disegno feroce del tempo sui corpi, la forza inarrestabile della regressione, appena interrotta, in uno squarcio poetico, dall’incontro struggente con l’antico furgone a forma di cane, Mutt Cutts, che, come la slitta Rosebud, testimonia l’incursione, in forma di miraggio, di un cinema - e di un discorso - destinato alle fiamme e alla distruzione.
Foudre (Manuela Morgaine)
Thursday, 16 April 2015 22:56Dalla parte della luce
Roberto Silvestri
Foudre, folgore, di Manuela Morgaine, 4 stagioni all’inferno. 1. L’autunno. Francia del sud: i cacciatori di saette fotografano il buio lacerato e la mappa dei fulminati. I sopravvissuti alle scariche da 300 milioni di volts mettono in scena il trauma e le evoluzioni impazzite delle sfere di fuoco.
2. L’inverno. Dopo il doc, l’horror: i depressi catatonico-malinconici ritrovano il “doppiaggio vocale” del loro dolore muto nell’elettroshock, perchè uno psichiatra eterodosso, pronipote afro-lusofono di Fanon, imprigionata quella sovrumana scarica cosmica nella macchina, schiaccia con quel male più forte e veloce un male più debole ma indelebile. 3. La primavera. Il cinema-saggio, di sommo valore archeologico perchè i templi siriani che ammiriamo non esistono più. Rasi al suolo da Assad. In Aleppo, tra i ruderi preislamici, il “folle” stilita visse secoli fa per 40 anni sulla colonna trovando dio, facendosene attraversare e sopravvivendo all’illuminazione non solo mistica: i fulmini fecondano la terra di kama, raro tartufo afrodisiaco. 4. L’estate. Il cinema-teatro: un dramma di Marivaux sulla battigia, La Disputa, l’amore è un colpo di fulmine anche tra due corpi educati illuministicamente come automi…
Se il cinema vendica i vinti del passato, è “spettrografia di Marx”, visto che è trappola di luce vellutata, e, nella ricezione, anche “sedia elettrica”, esperienza eterotopica e eterocronica, vendicherà anche le vittime dei fulmini (sacerdoti e campanili delle chiese, però, i più colpiti)? Per sfuggire alla bellezza sublime ma esiziale della scarica “anarchica” si consigliavano corone d’alloro. Già. Il film è anche perversamente, alchemicamente, dalla parte della luce. Come se indossasse la mitra sacerdotale che, prima del parafulmine, proteggeva i popoli. Il racconto egizio della creazione ricorda che l’Antenato tese l’arco, il buio si squarciò e dalla sua ferita sgorgò un fiotto di luce. Il cappello dei faraoni clematidi ha la curvatura dell’intensità luminosa nelle varie ore del giorno. La curvatura di Interstellar, di Si alza il vento… La curvatura opposta alla svastica hitleriana.
Pain and Gain (Michael Bay)
Thursday, 16 April 2015 14:53Il futuro alle spalle
Giona A. Nazzaro
Collocato fra il terzo e il quarto capitolo dei Transformers, Pain and Gain (Dolore e guadagno), è il suicidio commerciale di Michael Bay. Film costato relativamente poco rispetto alle macchine cui il regista ci ha abituato, è una sorta di catalogo delle brutture e delle mostruosità. A vederlo senza badare ai credit, si penserebbe a un film di George Armitage periodo Miami Blues. Stesso tocco ultrasgradevole, medesima spietatezza nei confronti dell’idiozia. Ma è un film di Michael Bay, probabilmente il cineasta di maggior successo economico degli ultimi decenni. Ed è un fallimento, voluto, cercato. Praticato come se il cinema non avesse futuro. E non è un caso che all’inizio del quarto capitolo della saga dei Transformers, il robot-camion si trovi dimenticato in un cinema in disuso. Bay, in termini strettamente industriali, si concede il lusso di produrre il film a medio budget che a Hollywood nessun grande produttore ha più intenzione di fare. Si inizia a parlare di produzione a partire da 100 milioni in su. Bay un passo indietro. Il futuro può stare alle spalle, non necessariamente sempre davanti agli occhi. Si proietta all’indietro in un’ipotetica zona temporale settantesca, recupera un’arrogante anarchia formale che sa molto di Corman gonfiato agli estrogeni e, così facendo, fornisce anche un preciso indizio su cosa è cambiato nel cinema americano dagli anni Ottanta in avanti. La follia di Pain and Gain, il suo violento e sgradevole nichilismo, sono il segno della consapevolezza di chi, in assenza di un discorso critico, si permette di autoprodursi il discorso sullo stato delle cose dell’industria cinematografica. Fallire, economicamente, realizzando il film più teorico prodotto a Hollywood da un regista che non si chiama né Fincher e né Anderson. E soprattutto, significa mettere in luce quale è il pensiero cinematografico che non avrà più cittadinanza né tanto meno futuro a Hollywood a meno che non si accetti il rischio di un inerente vizio di forma. Ed è solo così che si spiega poi il luddismo merceologico dei Transformers.
American Sniper (Clint Eastwood)
Thursday, 16 April 2015 14:26Straightshooting in the Dark
enrico ghezzi
Affrontare di petto il fantasma della visione è la situazione estrema di American Sniper. Film isolato e nudo, sconta senza paura la scabrosità scabra del soggetto facendo rimbalzare su chi lo guarda l’intensità concentrata di tale paura, e la sfida frontale al desiderio spettacolare. Non meno di un godard, eastwood si pone in regia raffinando il proprio autoritratto e provocando gli altri col gioco della distanza/vicinanza delle immagini. La purezza nera del film colpisce nel segno: fin dall’inizio sarà chiara l’invisibilità della cosa, e che la cosa è l’invisibile. Il west del cinema ha già compiuto diversi giri del mondo. Al cecchino il compito insensato di dare un senso alla singola pallottola, nella redroom della sua arma si forma e si disfa l’immagine di morte. Mediatore fatale tra un dio e il destino, sembra il resto ultimo dell’umano in una guerra mai più riconoscibile. L’immagine è distanza irrimediabile, che non può essere colmata scendendo sul set, nel qual caso sei tu stesso mutato in ‘immagine’; (‘se mi vedi sei morto’; A Casa dopo l’uragano di minnelli, l’esitazione prima di sparare, quella di deniro (Il Cacciatore) di fronte al cervo; o di walterpidgeon con hitler nel mirino in ManHunt; a casa non manca la bibbia, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi –quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che era da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia - In questa notte che fugge dall’alba accendo meccanicamente la tv e trovo i titoli di testa di Come in Uno Specchio di bergman - Lontano sta l’appassionante Redacted di depalma e lontanissimi restano i neoclassici della bigelow - Irresistibilmente mi trovo a evocare (nonsoperchè; la storia del cinema è sempre da rifare) Romantico Avventuriero (Gunfighter, 1950), psicodramma western dark sublime di henryking con gregorypeck)… E il cecchino record rimasto bambino mi fa assurdamente pensare a un altro uomo senza qualità (vedi magari i bellissimi pezzi di musil sulla rivista delle truppe austriache al fronte). Per straight che sia lo shooting, con la cadenza dei quattro ‘viaggi’ del protagonista sul fronte medio-orientale tutto (perché casa e teatro di guerra hanno la stessa distanza filmica dall'immagine, sono lo stesso cinema), precipita verso la nuvola tempestosa di sabbia che acceca e salva fino a un ‘vedere faccia a faccia’ con gli occhi stretti, intravedendo nulla (come non ricordare qui Fear and Desire, il film primultimo di kubrick, il più ‘faccia a faccia’ e il più sottovalutato del ventunesimo secolo?). Eyes Wide Shut fu già Eyes Wide Shot.
Jauja (Lisandro Alonso)
Wednesday, 15 April 2015 12:36Il prisma di Jauja
Luigi Abiusi
Sintesi inaspettata tra eidetismo (in modalità di rimando, concentricità di immagini), fenomenologia e, in mezzo, ermeneutica come essenziale tramite linguistico (tra fenomeno e sarabanda iconica), Jauja scava dentro quella ferita aperta, quell’aporia che è l’immagine cinematografica e, in genere, ogni congrua sedimentazione di senso, cioè votata all’alterità, all’invisibilità, all’incongruenza. Sintesi non didattica, gnomica, ma verificabile nella disgiunzione, in un procedere di senso che esce cioè dalla sinossi per altre ipotesi che si perdono dentro le spire dello spazio e del tempo: vortice nel mare di Solaris o semplice sasso lanciato in uno stagno, che è poi (o prima), per cerchi concentrici sull'acqua, la scogliera argentina, nel finale tarkovskiano.
Appare subito brulicante e inquietante lo squarcio sul fenomeno costiero, perfettamente digitalizzato e incorniciato: spazio di roccia ricoperto dal verde smagliante delle alghe, così fulgido e fluido nelle riprese in macchina digitale, che viene come smorzato e imprigionato dal quadro in 4:3, per ricondurlo a illustrazione, cosa morta, crosta ottocentesca. Ed è questa la natura del film: il conflitto tra griglia anticante, archetipica, che tenta di calcificare la dinamica della veduta, e volontà da parte del fenomeno, delle essenze delle cose, di muoversi, avanzare per liberarsi dei contorni. Ma Jauja in quanto apparente neutralizzazione di forze non è certo un’involuzione del cinema di Alonso; anzi è il sorprendente scarto in avanti, verso la coscienza dell’innata velleità essenziale dell’immagine in movimento, nel metabolismo di una dialettica di continuo annichilimento e rilancio della cinetica, tra le polarità della ripresa digitale fluidissima (più viva del mondo stesso) e la tensione ossificante (tanto maggiore in quanto in un 4:3 smussato) esercitata dai bordi.
Allora dentro la preponderante mimesi di Alonso Jauja fa emergere quella tentazione onirica che era come soffocata dal volume violentemente naturalista di un film come Los muertos; come un cortocircuito favoloso alla fine del viaggio del capitano Dinesen, stilizzato nel soldatino di legno (che è chiave onirica lynchiana che apre l’orizzonte alla ridda eidetica) ad evidenziare la natura prismatica del film. Ma non è il sogno fatto da Ingeborg nell’enorme casa danese, o non è solo questo. È il sogno del dispositivo-film-prisma attraverso cui si vedono infinite realtà in regime di straniante, metamorfica eppure intima reciprocità.
Antropologhia (Malastrada)
Monday, 13 April 2015 15:07Ritratto di una catastrofe
Donatello Fumarola
Antropologhia non ha futuro perchè innanzitutto è fuori dalle mode culturali e dai modi imprenditoriali dello spettacolo dominante e della sua economia (a partire da quella festivaliera). Perchè è scomodo a vedersi, non produce bellezza, è il ritratto di una catastrofe (la nostra) senza alcuna consolazione (a partire da quella estetica). Perchè Malastrada, il collettivo che lo ha realizzato, non si vuole far digerire come un qualsiasi fast food e non si offre al pret-à.porter. E a ragione. In qualche modo pratica il motto debordiano: il futuro sarà un rovesciamento di situazioni o niente. E in questo senso il futuro del film gli è esterno, legato a quanto il film può spostare, provocare, rivoltare (nel presente). Per questo riescono a farsi cacciare dalle mostre d’arte contemporanea a cui sono spesso invitati in giro per l’Europa. Malastrada produce conflitto. E lo produce in senso politico, non solo ‘estetico’, e non solo a parole. Il film non ha nulla di feticistico, nemmeno in senso negativo. Piuttosto il contrario.
Antropologhia è un film che non solo non ha futuro, ma non ha nemmeno un passato. Proiettato solo una volta a Roma al Teatro Valle Occupato senza la bellissima ora finale, La scomparsa dell'ombra. Finì lì in malomodo. E nulla più. E invece è un film prodigioso, che ha la pretesa di raccontare un popolo - il logos di un luogo (la Sicilia che c’è attorno a Paternò e lo Stato a Palermo e nei vuoti di Montecitorio) - attraverso le sue stesse immagini, autoprodotte, autoritratte (ovali, come le foto al cimitero), in epoca pre-smartphone (già lì, anzi qui, antropologicamente, a segnare quel futuro perpetuo che è questo presente). E forse non è nemmeno più un film, non lo è in senso più o meno classico né in quello ‘sperimentale’. Non appartiene a nulla di già visto, retoricamente. La cosa che gli va più vicino è il flusso televisivo da una parte, una sorta di montaggio automatico, per schegge, di durata variabilissima, letteralmente fuoritempo (anche e soprattutto quando filma il presente), e Lumière dall’altra, appunto: "l’invenzione senza futuro".
Torneranno i prati (Ermanno Olmi)
Monday, 13 April 2015 14:59La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza
Sergio M. Germani
Ci sono anche oggi dei grandi cineasti, e da tempo sappiamo che non devono per forza essere giovani, la vecchiaia è anzi il luogo in cui si rafforza la grandezza (da Ford a Dreyer a Matarazzo a de Oliveira). Scoprire che un cineasta in cui abbiamo potuto percepire anche qualche oscillazione di livello, “giunga” oggi a una inequivocabile grandezza ci rende felici. E naturalmente la cosa non viene intesa, e perlopiù si tratta Torneranno i prati con discorsi di doveroso rispetto. E il suo toccare la grande guerra come un umanitarismo senile, consono alla proiezione alla presenza di Napolitano di un film sostenuto dal Ministero. Anzi, c’è chi sottolinea che sul set Olmi dovette affidarsi a un qualsiasi Zaccaro, non cogliendo che in ciò egli alfine raggiunge la libertà di Rossellini verso il cinema. Il titolo stesso del film simula un’adesione all’ottimismo del ritorno in vita, ma vuol dire altro, che la vita successiva è stata condannata a dimenticare le morti, a mutare il fertilizzante dei cadaveri nell’eterno ritorno dei prati. Il “regista cattolico” che in E venne un uomo seppe problematizzare il corpo del papa nella reincarnabilità di un attore, che in L’albero degli zoccoli potè interrogare la sicurezza cristiana del sacrificio animale nel rito della sopravvivenza degli esseri umani, che in Centochiodi toccò il lato diabolico della santità, giunge qui a sussurrare una bestemmia verso un Dio che non ha salvato gli uomini a cominciare da suo figlio. Giunge anche al nichilismo della natura (paesaggi, animali...) che la guerra fa lambire come territori irraggiungibili proprio quando appaiono vicini allo sguardo come nello stupore di Stavros Tornes; e all’eclissarsi della donna di cui il soldato nella distanza trattiene solo la natura del tradimento. Dobbiamo rivedere gli Olmi che seppero accogliere e distornare le “rivoluzioni” degli anni '60 e '70 perché in questo presente del 2014-2015 egli raggiunge l’indispensabilità più pura.
La storia della principessa splendente (Isao Takahata)
Monday, 13 April 2015 14:48L’incanto dell’impossibile
Mariuccia Ciotta
Forme di acquarello in dissolvenza incise su carta di riso, fluttuanti e irrequiete, La storia della principessa splendente (Kaguya-hime no monogatari) cattura i fantasmi della favola millenaria (Il tagliatore di bambù) e li sospende in una spazialità senza limiti, i contorni in continua fuga nella zona bianca del non-essere. Un limbo candido dove l’immobilità del segno è scosso da vibrazioni acustiche e sensoriali. Ideogrammi del X secolo macinati al computer da Isao Takahata.
Evoluzione di un germoglio di canna e di una bambina in miniatura coperta di broccato rosso che cresce miracolosamente nel palpitare delle linee aperte. Un Voyage dans la Lune in senso inverso. Kaguya scende dal globo luminescente per sottrarsi al cerimoniale divino, svincolarsi dal tempo eterno e provare l’ebrezza del vento e delle stagioni, per vivere. Ma tra cielo e terra, irrealtà e materia, c’è solo un’esile barriera. Né l’aldilà né l’aldiqua garantiranno felicità alla principessa caduta dalle nuvole, circondata da bramosie sessuali, rapacità e aspiranti mariti insulsi e coronati ai quali chiede pegni d’amore introvabili: la sacra ciotola di Buddha, il ramo di un albero d’oro, la pelle di un topo di fuoco cinese, il ciondolo di un drago, la conchiglia nascosta nel ventre di una rondine.
L’inchiostro di china torna a recintare l’immagine, la zona bianca si restringe. E alla ricerca della frattura tra sogno e il suo rovescio, flebile passaggio di libertà, fuori dalla tradizione e dal presente, Takahata si allontana dalle tante versioni della fiaba ispiratrice di manga, videogiochi e serie tv.
Il film si inchioda nello sguardo perduto di Kaguya che esita a salire sul carro sontuoso venuto a riportarla nell'astro natale, quando nel testo originale, delusa dagli uomini, aspettava con trepidazione gli esseri celesti. Ed è in questo fermo immagine che l’animatore giapponese trova - sequenza spumeggiante di trasparenze e scintillii d'oro – la via per demolire il mito, e le principesse smorfiose di Frozen. L’incanto dell’impossibile che avrà luogo.
Ultimi articoli pubblicati
- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)
- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)
- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)
- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)